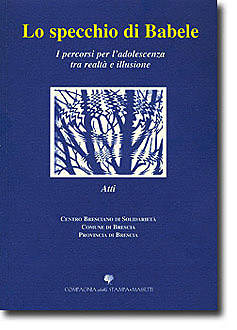Descrizione
RESISTENZA INCARNATA
Guardare l’abisso, guardare dentro l’abisso. Queste parole, che risuonano come un monito da prendere sul serio, accompagnano l’agile saggio qui presentato di Massimo Giuliani.
L’autore prende le mosse dalla nozione di tremendum, cifra dell’interpretazione coheniana dell’Olocausto, tentativo di esprimere e di significare il non-senso di ciò che è stato. Tentativo che è sempre destinato a inciampare in un linguaggio che si trasforma in balbettio ogni qual volta si cerca di esplicare ciò che, parafrasando Primo Levi, è impossibile comprendere, ma è necessario conoscere. Giuliani, invita il lettore, a una presa di coscienza, all’esercizio indispensabile di una «ragione etica» cercando di mostrare, fattivamente, come e perché si debba sperare dopo Auschwitz.
Crediamo che il grande merito di questo scritto risieda nel costante, insistente – come insistente è l’accadere dell’essere e del nostro esserci corporeo nella fatticità storica – richiamo alla «tenacia della vita». Quella stessa tenacia che dimostrarono gli ebrei negli anni bui e funesti della Shoah. Anni in cui non era più dato morire da individuo, ma come ridotto a tipo della specie e nei quali la distinzione tra vita e morte, «tra l’essere-ancora-qui e il non-essere-più», si era fatta terribilmente ambigua. Labile. Incerta. Se è vero, come è vero, che uno dei risultati nefasti cui portò l’Olocausto fu la messa in discussione del principio primo di ogni realtà: l’intrascendibilità dell’ordine della distinzione, è altrettanto evidente che «quell’antimondo» «ha creato la figura del “muselmann” (“il musulmano”), che nello slang dei campi di sterminio indicava il prigioniero prossimo alla morte, il quasicadavere ambulante ormai solo pelle e ossa, un morto vivente». A questa figura mirabilmente descritta da Primo Levi, in “Se questo è un uomo”, non era neppure permesso, se così si può dire, di «morire la propria morte» né tantomeno di sacrificare la propria vita per Santificare il Nome. Ecco perché, come ricorda Giuliani citando il rabbino Izchaq Nissenbaum, «oggi [nel ghetto di Varsavia] è il tempo del qiddush ha-chajjim e non il tempo del qiddush ha-Shem. In passato i nostri nemici chiedevano la nostra anima e l’ebreo sacrificava il suo corpo per santificare il Nome divino. Oggi ci chiedono anche i nostri corpi. Perciò è imperativo, per gli ebrei, difendere e proteggere anche i propri corpi».
Emil Fackenheim, nel suo saggio “Tiqqun. Riparare il mondo”, porta degli esempi concreti di che cosa significhi santificazione della vita. Subito dopo la testimonianza di Pelagia Lewinska – definita «una scoperta monumentale», poiché si tratta delle parole di qualcuno «che affrontò e combatté questa totalità orribile anche mentre era intrappolato in essa, e che, senza questa illuminazione, non avrebbe potuto fare quello che effettivamente fece»: sentirsi costretta a vivere nonostante tutto –, l’autore racconta di un kapò ucraino che, nel campo di Buchenwald, si offrì di vendere un paio di tefillin a un gruppo di chassidim, pretendendo in cambio quattro razioni di pane. Per costoro si pose un problema morale: il fatto di rinunciare a quell’unica fonte di sostentamento, li avrebbe esposti al rischio del peccato di suicidio; «ma il problema morale si era risolto da sé perché i tefillin, “una merce molto più preziosa” a Buchenwald rispetto al pane, erano anche pane: rafforzavano lo spirito, e dunque anche il corpo».
Per non dire di un altro toccante avvenimento, accaduto all’inizio della guerra in aperta campagna fuori Lublino, che, di nuovo, ha per protagonisti dei chassidim, costretti da un ufficiale tedesco, un certo Glowoznik, a cantare e a danzare al suo cospetto. Questi, intimoriti, «iniziarono il tipo di canto che i devoti intonano davanti alla morte: lomir zich iberbeten, Ovinu sheba-Shomayim, “Riconciliaci, Padre nostro celeste!”». L’ufficiale li esortò a cantare più forte, mentre essi gli stavano di fronte inermi, impauriti, braccati. Una sorta di paralisi interrotta da una voce che improvvisamente si levò da quella confusione. Quella voce recitava: «Mir welen sei iberleben, Ovinu sheba-Shomaym (“Sopravvivremo a loro, Padre nostro celeste!”)». Questo imperativo, che sembra fare da preludio a quello contenuto nel 614mo precetto esposto da Fackenheim in “La presenza di Dio nella storia”, che cosa ci insegna se non il fatto che l’unica risposta al male resta la resistenza fattiva, concreta al male in una celebrazione, nella e con la propria esistenza, della vita stessa? Che cosa spinse i protagonisti di questi exempla morali ad agire così? Perché lo fecero? Dove trovarono la forza? Ciascuno a suo modo, di fronte all’estremo, scelse la speranza e non la disperazione.
Scrive Fackenheim: «In una Umwelt la cui unica e definitiva espressione è un sistema di umiliazione, tortura e uccisione, il fatto che le vittime mantengano un brandello di umanità, non è solo la base della resistenza, ma è già parte integrante di essa. In un mondo simile – questa è la testimonianza delle madri, dei molti di cui si fece portavoce Pelagia Lewinska, dei combattenti dei ghetti e dei campi, e dei chassidim di Buchenwald e di Lublino – la vita non ha bisogno di essere santificata: è già santa. Questa è la definizione di resistenza che cercavamo».
Una resistenza che, se fu possibile nell’orrore del totalitarismo e della sua totalità onniavvolgente, tanto più deve essere praticata oggi contro qualsiasi forma di oppressione, persecuzione, usurpazione del posto al sole di Altri.
«La resistenza al mondo dell’Olocausto – che è un novum della storia – è a sua volta un novum», al punto da divenire categoria ontologica: essere testimoni del male radicale, «non significa comprenderlo o trascenderlo, ma piuttosto dirgli di no, resistergli. Il mondo orrendo dell’Olocausto è (perché è stato); ma non deve essere (e non doveva). Non deve essere (ed è stato), ma è (perché è stato). Il pensiero cadrebbe nell’evasività se si limitasse al “non dover essere”; e cadrebbe nell’impotenza paralizzata se affrontasse, inerme, solo il devastante “è”. Solo tenendo saldamente fermi nel contempo “è” e “non dover essere”, il pensiero può guadagnare una sopravvivenza autentica”. Il pensiero, cioè, deve assumere la forma della resistenza». Il male resta la penultima parola, mentre il come e il perché sperare – per un verso, attraverso atti resistenziali concreti, per l’altro, eseguendo il 614mo precetto: sopravvivere per non dare una vittoria postuma a Hitler – non sono altro che l’unica declinazione possibile di «una resistenza che non sia nel “mero pensiero”, ma in un’azione pubblica, in una vita in carne e ossa», ossia di ciò che potremmo chiamare resistenza incarnata. Levinasianamente uno «sperare per il presente» che consiste nel volgere la sofferenza inutile e scandalosa in sofferenza non inutile e che implica il prendere sul serio il fondamento ultimo della nostra umanità: l’assunzione, nel nostro temporalizzarci, della felix culpa. In ultima analisi, la resistenza incarnata si dà nei termini di un «essere ostaggio», che «è forse solo – rivelò Emmanuel Levinas a Bernhard Casper in un colloquio svoltosi a Parigi nel 1981 – un nome più forte per dire l’amore».
F.N.