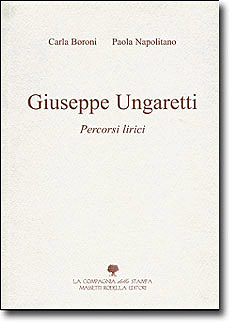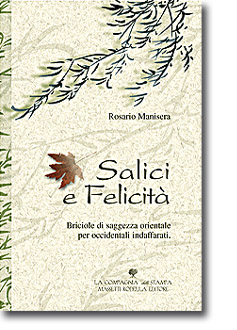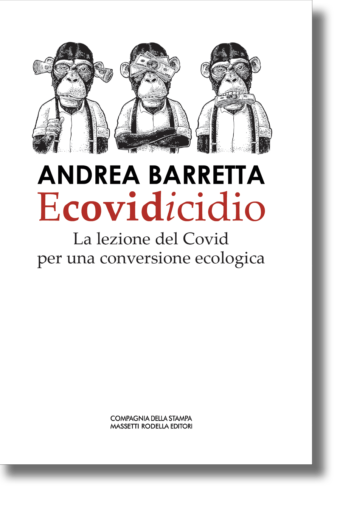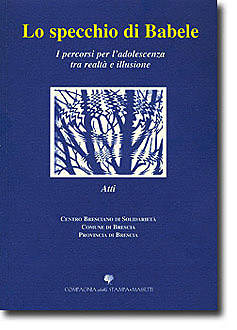Descrizione
FARSI GIUSTI
Nel ripercorrere le attività di Gariwo, il Comitato per la Foresta dei Giusti, che ha iniziato a operare a Milano nel 1999 e si è costituito ufficialmente nel 2001 ponendosi al servizio della memoria, il suo Presidente, Gabriele Nissim, che è anche l’Autore del saggio qui presentato affronta con lucidità e chiarezza il concetto di giusto e il suo stretto, indispensabile legame con la memoria e l’educazione alla memoria, pervenendo a una circolarità virtuosa tra i tre elementi quasi che dalla loro stretta connessione potesse esplicarsi il paradigma della memoria del bene. Un paradigma che, se così si può dire, ha trovato la sua consacrazione nell’approvazione da parte del Parlamento di Strasburgo della Dichiarazione scritta n. 3/2012, recante 388 firme, che istituisce il 6 marzo come Giornata Europea dei Giusti, invitando gli Stati a farsi carico di questo imperativo di onorare le figure morali che seppero opporsi ad ogni forma di totalitarismo, di persecuzione e di genocidio mettendo capo a una resistenza non violenta. Risiede in ciò il valore aggiunto dell’universalizzazione del concetto di giusto che, a nostro parere, trova la sua forza non tanto nel tentativo – esercizio teorico piuttosto sterile – di pervenire a una mera definizione di chi è il giusto, bensì nel concentrarsi sul come quella persona, quell’individuo che merita di essere tratto dall’oblio per illuminare i nostri giorni ergendolo ad esempio ha saputo far fronte all’oppressione, alla violenza, al rancore, all’odio, alle minacce. E questo, anche a costo di perdere la propria vita, di prendere su di sé le sofferenze di Altri fino a farsene ostaggio, come se in ciascun giusto risuonasse il monito dei Pirqè Avot: «Dove non ci sono uomini, sfòrzati di essere un uomo». Come scrive acutamente Abraham Joshua Heschel: «L’uomo raggiunge la pienezza dell’essere nel legame sociale, nell’interesse per gli altri. Amplifica la sua esistenza “portando il fardello del suo prossimo”. […] In termini biblici il problema centrale non si formula chiedendosi: “Cosa significa ‘essere’ ”, bensì chiedendosi: “Come si deve essere e come non si deve essere?”. Infatti, il problema che ci si presenta non è la dicotomia tra l’essere e il mancato essere, bensì quella tra l’essere giusto e l’essere ingiusto. La tensione non è tra esistenza ed essenza, ma tra esistenza e svolgimento. Per gli animali, come pure per gli esseri umani di fronte al pericolo e all’angoscia, il problema è quello di essere o non essere. Ma ciò che caratterizza un essere umano sta nel modo di essere o non essere». Non è casuale, dunque, che l’Autore concentri la sua attenzione su quattro modalità dell’essere giusto, precisando che «la definizione del giusto di fronte a un crimine contro l’umanità rimane sempre aperta» e in costante divenire, poiché il soggetto non è un ego trascendentale, una monade senza porte né finestre, ma è un «io sono» di carne e di sangue che nell’hic et nunc della propria fatticità storica si temporalizza decidendosi o meno – in ciò sta la sua libertà – a iniziarequalcosa-con-se-stesso e, dunque, facendosi accadere nell’incontro con l’Altro. In questo decidersi a riconoscere che di fronte a me c’è un Altro sta, secondo Levinas, la mia responsabilità che «mi incombe in modo esclusivo e che, umanamente, io non posso rifiutare. Questo onere è una suprema dignità dell’Unico. Io non-intercambiabile, sono io soltanto nella misura in cui sono responsabile. Io posso sostituirmi a tutti, ma nessuno può sostituirsi a me: è questa la mia inalienabile identità di soggetto». Che poi questa responsabilità si esplichi nelle categorie dei giusti individuate dall’Autore in «chi presta soccorso a una vita in pericolo e chi denuncia un genocidio; chi non accetta la delazione e la menzogna e difende la pluralità umana; chi salvaguardia la propria dignità non accettando di farsi corrompere nelle situazioni estreme; chi difende la memoria di un genocidio di fronte ai negazionisti», questo non fa che confermare che giusti non tanto si è, ma ci si fa ponendo in essere una resistenza in carne ed ossa che ci fa dire che una responsabilità incarnata è possibile se davvero si vuole cogliere l’«io sono» nell’unica maniera che gli è data, ovvero come io «corporalizzato», mortale e finito: «Il corpo – scrive Levinas – non è né l’ostacolo opposto all’anima, né la tomba che lo imprigiona, ma ciò per cui il sé è suscettibilità stessa. Passività estrema dell’“incarnazione” – essere esposto alla malattia, alla sofferenza, alla morte, è essere esposto alla compassione e, Sé, al dono che costa. Al di qua dello zero dell’inerzia e del nulla, nel deficit d’essere in sé e non nell’essere, precisamente senza luogo dove posare il capo, nel non-luogo e, così, senza condizione, il se stesso si mostrerà portatore del mondo – il portante, il sofferente, fallimento del riposo e della patria, e correlativo della persecuzione – sostituzione all’altro». Se si guarda alle figure che sono onorate, nella prima edizione della Giornata Europea dei Giusti, in occasione della quale, nel celebrare questi testimoni della memoria del bene, viene inaugurato in partnership con Gariwo, con il Comune di Brescia e in collaborazione con la Casa della Memoria, il Giardino dei Giusti in un’area del Parco Tarello di Brescia, si nota come il fatto dell’essere giusti passi – pur nella pluralità e nella diversità delle scene del male in cui ciascuno si è trovato a dover far fronte –, per un verso, attraverso gesti, atti concreti – diciamo pure di resistenza incarnata –, per l’altro attraverso l’opposizione ferma e convinta all’ottusa obbedienza al potere, alla cui origine sta, come ha mostrato in maniera illuminante Simona Forti nel suo volume I nuovi demoni, un ripensamento del male politico che vada al di là del paradigma Dostoevskij – teso nella dicotomia tra soggetto onnipotente e vittima assoluta – puntando «lo sguardo non tanto sulla “colpa” della trasgressione quanto sulla subdola normatività del nongiudizio, fatta propria ed esaltata da quella morale che così spesso ci ha insegnato che giudicare è il segno della superbia, è l’ombra del primo peccato commesso dai progenitori: il peccato della disobbedienza. […] “I demoni assoluti” esistono – spiega la filosofa – ed esistono ancora oggi, ma se le loro iniziative hanno successo è perché si integrano perfettamente con il desiderio di tutti coloro che, troppo occupati a consolidare le loro opportunità di vita, si adeguano senza reagire». Del resto Patocˇka ispiratore e firmatario di Charta ’77, morto d’infarto dopo esser stato sottoposto a un’estenuante interrogatorio da parte della polizia del regime, a cosa mise capo con i suoi appelli all’«uomo spirituale», al «sacrificio», all’epiméleia, alla «comunità degli scossi», se non a «un gesto parresiaco che è diventato l’esempio – e non solo in Cecoslovacchia – di un pensiero che è riuscito a farsi prâxis, senza diventare dottrina»? Allora «che cosa ci hanno insegnato le sanguinose guerre del ventesimo secolo e le ideologie che le hanno ispirate? Quale “segreto” dell’epoca ci sta svelando Patocˇka? Che un rapporto distorto tra la vita e la morte ha raggiunto nel Novecento il proprio vertice di perversione. Innanzitutto perché in nome della pace, sotto il cui vessillo si conserva la vita, si è organizzata e si continua a organizzare la messa a morte. L’“escatologia della pace”, che sostiene il proclama di un domani migliore – continua Forti – è la parola d’ordine per cui “siamo morti a milioni”, tanto da riuscire a trasfigurare la morte di massa in una spiacevole interruzione temporanea, ma necessaria, del grande disegno della continuità della vita. […] Il messaggio finale di Patocˇka – sottolinea la studiosa – ci giunge inequivocabile: non è dunque la morte la grande signora incontrastata del secolo, ma la vita, quella vita che monopolizza e cattura tanto i singoli quanto le collettività». E che dire del grande giurista ebreo polacco Raphael Lemkin che – venuto a conoscenza fin dall’adolescenza dello sterminio del popolo armeno da parte del governo turco, costretto lui stesso ad emigrare negli Stati Uniti per sfuggire alla furia nazista, mentre quaranta membri della sua famiglia venivano sterminati nella Polonia orientale – formulò la definizione di genocidio, redigendo il testo della convenzione che sarebbe stata approvata all’unanimità dall’Onu il 9 dicembre 1948? Una lotta senza tregua alla menzogna che spezza le catene di chi diviene suddito del potere, che si trova in un altro giusto: mons. Carlo Manziana, sacerdote della Congregazione dell’Oratorio nominato vescovo di Crema, grande amico di Paolo vi e di padre Giulio Bevilacqua, educatore, maestro di fede e di vita che fu deportato al campo di concentramento di Dachau, ritenuto colpevole di aver «traviato» schiere di giovani studenti, avendo insegnato loro «a pensare e a ragionare contro le Organizzazioni e le direttive del Regime» (Rapporto Bozzi, sull’attività antifascista della Pace, 7 giugno 1940). Rimase in quell’inferno per 16 lunghi mesi distinguendosi, subito, nel Lager per la sua infaticabile opera di umanità: entra nelle baracche, in particolare nella 25, dove sono ammassati più di duemila connazionali, varca i cancelli del Revier, il terribile lazzaretto, per portare conforto e alleggerire la sofferenza dei compagni di prigionia sforzandosi di vincere con il bene il male (cfr. Rm 12, 21). «Padre Carlo – scrive un altro oratoriano doc, padre Giulio Cittadini – ci aiutava a cogliere il frutto della libertà e a gustarlo. Era un aristocratico dello spirito, aveva il culto dell’intelligenza e un fine umanesimo. Come avrebbe potuto sopportare la volgarità e la violenza dell’ideologia dominante, piegarsi al suo tentativo di plagio totale, di autentico vampirismo spirituale? In questo Padre Manziana – argomenta p. Cittadini, che scelse come nome di battaglia, allorché fu inquadrato nella 76a Brigata Garibaldi, il nome di Manzio per ricordare il suo allora assistente alla Fuci – era un fedele interprete del suo grande maestro P. Giulio Bevilacqua, irriducibile nemico dei nemici dell’uomo e Dachau fu il terribile luogo della sua coerente testimonianza. Tornato a casa, alla Pace, P. Manziana riprese con accresciuto prestigio il suo difficile apostolato: avvicinare il più possibile la cultura alla fede e la fede alla cultura» nello spirito di una libertà evangelica. E ancora, Teresio Olivelli, il ribelle per amore, protagonista della Resistenza nel triangolo Brescia-Cremona-Milano, il quale fu in stretto contatto, fin dal suo primo arrivo a Brescia, l’11 novembre 1944, con gli esponenti del movimento ribellistico locale tanto che la sera stessa fu condotto dall’amico Romeo Crippa a una seduta che questi tenevano nella chiesa parrocchiale di S. Faustino. All’adunanza, presieduta da Astolfo Lunardi, c’erano tra gli altri Peppino Pelosi e, non a caso, padre Manziana. Costante fu la collaborazione, come scrive Alberto Caracciolo nella sua biografia, con «l’ambiente di quel mirabile centro di educazione che era in quella città costituito dal Convento Oratoriano della Pace (quante generose e alte figure – continua Caracciolo – di giovani usciti da questo oratorio non conta la Resistenza tra i suoi migliori rappresentanti o tra le sue vittime)». Per sua opera e volontà nacque il giornale «Il ribelle», il cui primo numero datato da Brescia, 5 marzo 1944, lo volle dedicare per intero alla memoria di Astolfo Lunardi e di Ermanno Margheriti, condannati a morte dal Tribunale speciale di Brescia il 5 febbraio e fucilati il mattino del 6 al Poligono di Mompiano. Il saluto all’amico, nel quale riecheggia la sentenza evangelica, si potrebbe considerare come il testamento spirituale di Olivelli: «Solo chi la vita la getta senza misura può dare e avere la vita». Come significativo è l’articolo programmatico “Ribelli”, apparso nel secondo numero del giornale, dove scrive: «La nostra è anzitutto una rivolta morale. Contro il putridume in cui è immersa l’Italia svirilizzata, asservita, sgovernata, depredata, straziata. […] Contro la massa pecorile pronta a tutti servire, a baciare le mani che la percuotono. […] Contro una cultura fradicia fatta di pietismo ortodosso e di sterili rimuginamenti, di sofisticati adattamenti, incapace di un gesto virile. […] Mai ci sentimmo così liberi come quando ritrovammo nel fondo della nostra coscienza la capacità di ribellarci alla passiva accettazione del fatto bruto, di insorgere contro il bovino aggiogamento dello straniero, di risorgere a una vita di intensa e rischiosa moralità». Olivelli, catturato il 27 aprile 1944 a Milano e carcerato a S. Vittore, dove fu torturato, fu trasferito a Fossoli, poi a Bolzano, Flossenburg, e infine a Hersbruck. Visse la sua prigionia facendosi, come direbbe Levinas, ostaggio per l’Altro fino alla donazione totale: «sorpreso mentre si adoperava a difesa dei compagni, fu da un guardiano polacco colpito con un calcio brutale allo stomaco: a questo s’aggiunsero 25 gommate date con quella ferocia cui un tempo non poteva pensare riuscisse a scendere l’imbestiamento dell’uomo». Morì dopo pochi giorni il 17 gennaio 1945. Un’agire in nome del Bene che contraddistinse Etty Hillesum – la giovane ebrea olandese morta ad Auschwitz a ventinove anni – che seppe testimoniare con la sua stessa esistenza l’amore per l’umanità «la cui definizione migliore – scrive J.G. Gaarlandt nella sua introduzione al Diario 1941-1943 – è “altruismo radicale”»: non rispondere all’odio con l’odio, ma mettersi alla ricerca del bene nascosto nell’intimità di ogni individuo. Un intendimento che Etty seppe condensare in queste parole: «si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite». Innamorata della vita, nonostante tutto, arriverà a scrivere il 6 luglio 1942: «Sono in uno stato d’animo così singolare. Sono proprio io a scrivere qui, così tranquilla e matura – qualcuno mi potrebbe capire se dicessi che mi sento stranamente felice, non in modo artificioso o altro, ma in tutta semplicità, perché mi sento crescere dentro dolcezza e fiducia, di giorno in giorno? Perché tutta la confusione, le minacce e i pesi non mi portano neanche per un momento all’alienazione mentale? Perché continuo a vedere e a sentire la vita così chiara e nitida in tutti i suoi contorni. Perché nulla offusca i miei pensieri e i miei sentimenti. Perché sopportare e accettare tutto e perché la coscienza del bene che c’è stato nella vita – anche nella mia vita – non è stata soppiantata da tutte queste altre cose, anzi diventa sempre più parte di me». Per concludere, come non ricordare Angelo e Caterina Rizzini, che salvarono la vita a Emma Viterbi e al secondogenito Paolo sfidando le leggi razziali fasciste a rischio della vita, mentre il marito Guido e il figlio Alberto Dalla Volta, ricordato da Primo Levi in “Se questo è un uomo”, morirono ad Auschwitz? Se ancora vi fossero delle esitazioni sul perché queste persone possano rientrare nel novero dei giusti, basti la risposta che Jean Luc Nancy, uno dei maggiori filosofi contemporanei, offre sforzandosi di spiegarlo a dei bambini. Egli scrive: «Sono stati chiamati “Giusti” coloro che non sapevano niente delle persone che salvavano o che tentavano di salvare, spesso rischiando grosso, rischiando, semplicemente, la propria vita. Sapevano soltanto questo: che quelle persone avevano diritto a un riconoscimento infinito, senza limite, anche a rischio della propria vita. […] Credo che un’idea – continua Nancy – dovrebbe dominare il nostro pensiero: che il giusto, stavolta nel senso della qualità, del fatto di essere giusto, sia dare a ciascuno ciò che non si sa neanche di dovergli». Come si evince dalla testimonianza di queste figure che si ergono a esempi morali il compenetrarsi di atti segnati da una responsabilità incarnata con ciò che Foucault chiamava «contro-condotte» rinvia a quell’orizzonte fecondo del farsi giusti, sotteso da quella piccola, ma indispensabile bontà di cui parla Vasilij Grossman in Vita e destino: «È la bontà dell’uomo per l’altro uomo […] la bontà è debole, fragile: questo è il segreto della sua immortalità. Essa è invincibile. […] Il male non può nulla contro la bontà. […] La bontà, amore cieco e muto, è il senso dell’uomo». Forse sta proprio nella scoperta di questo segreto che anima chi si fa giusto, chi si decide-per-l’altro senza se e senza ma, il grande valore terapeutico dell’educare alla memoria.
F.N.