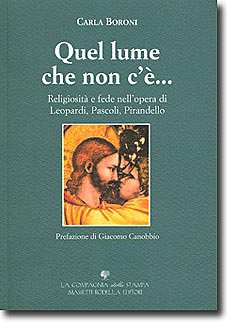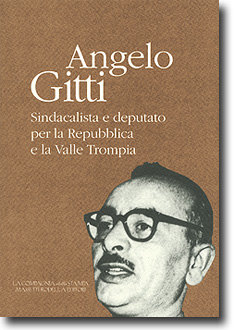Descrizione
Salvatore Natoli, tra maggiori filosofi italiani, è anche il pensatore che nel nostro Paese ha maggiormente riflettuto su ciò che già Aristotele chiamava il fine ultimo di ogni essere umano. Da “La felicità” a “La felicità di questa vita” a “Il dizionario dei vizi e delle virtù” Natoli ha saputo offrire una disamina rigorosa e penetrante di un tema con il quale non ha mai smesso di confrontarsi, quasi costituisse una delle architravi su cui poggiano anche le sue ultime opere: da “Il buon uso del mondo” fino alla “Edificazione di sé”.
Tema centrale dell’esistenza, la felicità è quella condizione in cui ciascuno di noi vorrebbe sempre stare. Addirittura, come ricorda l’autore, v’è inscritta nelle nostre carni una dimensione immemorabile della felicità, che ci permette di far fronte anche ai momenti più bui della nostra vita, perché proprio rammemorando il tempo della pienezza si può contrastare il dolore che ci rende muti. Ma la felicità è soltanto un sentimento che, come tale, è passeggero, viene e va o è, piuttosto, ciò che si configura come uno status? Come il predicato della vita intera? Natoli, descrive dapprima la felicità che, per richiamare Agostino, raptim quasi per transitum. Un vortice, una situazione in cui esperiamo la nostra illimitata espansione e insieme l’impossibilità di reggere a lungo a una tale condizione. A differenza degli dèi per quali la vita scorre beatamente, gli umani che pure, come scrive Rilke, possono toccare in quell’istante l’acme – gli amanti lo sanno – avvertono insieme lo struggimento per una felicità che non può durare a lungo. Siamo stati insieme un giorno, una settimana. Siamo stati là, ma ora si deve andare, ora ci si deve congedare.
Non a caso Natoli porta l’esempio della “Creazione di Adamo” di Michelangelo ove tra il dito di Dio e quello dell’uomo si dà uno scarto. Sono vicini, ma non si toccano. Sono accanto. Lo stesso accade nella tensione tra la perdita e l’acquisto, tra una mancanza e il suo soddisfacimento. E più c’è tensione, più il sentimento della felicità si accresce. Ma siamo proprio sicuri che la felicità sia soltanto ciò che viene da fuori, ciò che ci possono donare gli altri, in breve, ciò che ci accade?
Crediamo risieda proprio in questo interrogativo il grande apporto del pensiero natoliano. A partire dalla distinzione tra eutychía e eudaimonía, tra l’accadimento fortuito e il demone favorevole, l’autore fa notare come, a fronte di ciò che semplicemente accade, si dà la possibilità che sia l’uomo stesso a produrre la propria felicità. Avere un buon demone significa stabilire rapporti fecondi col mondo, mettersi alla prova, conoscere le proprie capacità e fare leva su di esse per realizzare se stessi. Che cos’è la virtù, se non l’abilità di trovare, al momento giusto, la soluzione? Contrariamente ad una concezione di virtù intesa in termini di obbedienza alla legge, di deficit della soggettività, Natoli rifacendosi all’etimologia stessa di aretê, da ars, arte sa scorgere in essa e nel suo esercizio quell’abilità che permette di governare il caso. Quell’abilità che più la si pratica, più la si fortifica al punto da divenire una buona abitudine. Quell’abitudine che permette al singolo di trarre da sé il bene. Ma per pervenire a ciò occorre, da un lato, conoscersi dall’altro, conoscere l’oggetto con il quale destreggiarsi.
Occorre, dunque, per un verso, vivere secondo natura ossia cercando di potenziare e fare leva sulle abilità che ciascuno possiede, per l’altro saper fare buon uso delle cose. Non basta possedere un violino per essere un bravo violinista o possedere una vela per veleggiare bene e meglio di altri. Appunto, la felicità non sta nel manufatto, ma nel modo in cui ci si rapporta alle cose. Una valorizzazione che diviene imperativo nell’incontro con l’altro. Altro che nella società liquida di oggi, quando va bene, viene ridotto a funzione, a numero, a mera prestazione. Di qui la depressione esistenziale che fa tutt’uno con la depressione economica globale, con la pericolosa conseguenza che nella confu-sione tra agire (dare un senso alle proprie azioni) e fare (eseguire un compito), siamo sempre più agiti e sempre meno agenti. Il nostro «stare al mondo», il nostro «avere mondo» non può che passare da questo recupero delle virtù, in quanto capacità di realizzare se stessi insieme all’altro. L’altro non è ciò che posso ridurre a me, asservire, assoldare, sfruttare. L’altro è proprio ciò che sfugge a questa presa, in quanto rifugge da ogni tematizzazione, da ogni oggettivazione. Altri, per richiamare Levinas, è «l’evento della rottura più radicale delle categorie stesse dell’io, poiché per l’io, questo evento significa non essere in sé, essere altrove, essere perdonato, non essere un’esistenza definitiva. La relazione con “altri”, non potrebbe essere pensata come un incatenamento a un altro io; e nemmeno come la comprensione d’“altri” che toglie a quest’ultimo la sua alterità o come una comunione con lui rispetto ad un terzo termine».
La felicità, dunque non risiede tanto nel possedere, che rende grevi e pesanti – consumatori distratti e infelici – ma nelle relazioni, nella capacità reciproca della donazione. Attraverso la strategia delle virtù si può giungere alla stabilità del bene. Su questo passaggio fondamentale ci pare sintomatico il convergere delle riflessioni di Salvatore Natoli e di Bernhard Casper sul carattere fecondo della felicità. Una vocazione questa che scaturisce dall’etimologia stessa del termine. Come scrive acutamente il grande filosofo tedesco: «nel vero “sono felice”, il ricevere passivo del dono e l’attivo realizzarsi nella gratitudine coincidono».
Forse, a partire da questa premessa, si potrebbe dire che l’uomo non è felice perché consuma, ma è felice perché si riconosce bisognoso di ciò da cui dipende e dell’altro che gli sta di fronte nella sua irriducibile alterità. Come non si stanca di ripetere Zygmunt Bauman l’uomo si preoccupa soltanto di suscitare altri consumi, altre domande e si è del tutto disinteressato del soddisfacimento dei bisogni primari. Egli si illude di avvicinarsi ad uno stato di felicità possibile, mentre si dimentica delle condizioni che possono condurci ad essa.
Come dire: l’uomo del consumismo continua a celare il suo autentico «io sono» e in un disorientamento sempre più preoccupante, si trova ad un passo dal baratro. In questa condizione solo il soggetto di carne e di sangue che ha bisogno dell’altro, o il che è lo stesso, che prende sul serio il tempo; solo un soggetto che si sa destreggiare nel mondo tornando alle virtù può costituire una risposta – essa stessa feconda – ad una situazione globale estremamente complessa e delicata.
F.N.