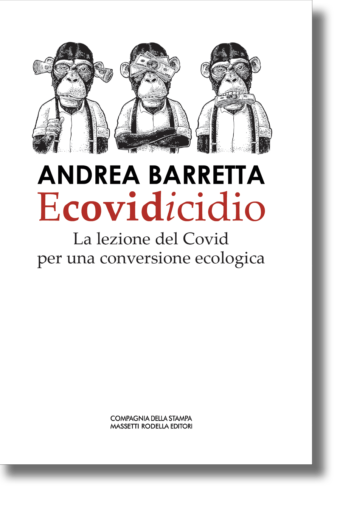Descrizione
RICORDARE PER RICOSTRUIRE
La prima impressione che affiora alla mente e al cuore di chi si accosta a questo testo è che ad essere trasmessa è l’umanità dell’uomo. Di un uomo semplice nella sua autorevolezza, eminente figura dell’ebraismo italiano e internazionale, tessitore instancabile del dialogo ebraico-cristiano. Una figura cui anche la nostra Associazione deve molto per quella consuetudine di amicizia e di stima che si è rinnovata nel tempo con il dono della Sua presenza e della Sua parola, della Sua fiducia e della Sua disponibilità. Del Suo ascolto.
Peculiarità queste che si addicono a pochi e che insieme contraddistinguono chi come Rav Laras – grande pensatore della filosofia medievale, Rabbino capo di Ancona, Presidente emerito dell’Assemblea Rabbinica Italiana nonché Presidente del Tribunale Rabbinico dell’Alta Italia e della Fondazione Maimonide di Milano – può essere senz’altro chiamato Chakham (saggio) e Maestro. Quest’uomo, ha un nome proprio, per usare un’espressione significativa di Franz Rosenzweig, è un essere di carne e di sangue come ciascuno di noi, che ha trovato il coraggio di raccontare la tragedia che ha investito la sua famiglia, condividendo con altri – cosa rara e che forse è accaduta un’altra volta soltanto – i suoi ricordi più intimi. Il grande rabbino dà subito l’impressione di andare alla cosa stessa, quasi volesse toccarla con mano trasmettendola, e da professore si fa testimone. Snocciola, non senza commozione, quasi a fil di voce, le date che hanno segnato, per sempre, la sua vita. Il ricordo di quel settembre 1943, durante il quale la gente che era sfollata sulle montagne, dovette scendere per evitare i rastrellamenti. Poi il luglio ’44, preludio di un epilogo terribile, che segna il trasferimento di lui, bambino, con la madre a casa della nonna. A Torino. Passano pochi mesi: il 2 ottobre, i fascisti bussarono ininterrottamente alla porta, minacciando di sfondarla, se qualcuno non l’avesse aperta. Erano stati denunciati da una delatrice, la portinaia del palazzo in cui abitava la nonna. I due fascisti disponevano di un elenco, ma
«in quella lista – racconta Rav Laras – non c’era il mio nome perché al delatore era sfuggito».
Per lasciarlo libero sua madre offrì tutti i risparmi accantonati – 20 mila lire in quei tempi era una cifra consistente – ed anche 30 pacchetti di sigarette conservate premurosamente in quegli anni di grande penuria e povertà. Poi venne il calar del sole: tutti e tre furono condotti verso l’Hotel Nazionale – sede della Gestapo – con l’accordo che il bambino sarebbe dovuto scappare una volta giunti in via Madama Cristina,
«appena superato l’incrocio con Corso Vittorio Emanuele».
«Mi ricordo che il fascista che mi teneva per mano non sembrò allentare la presa. Guardai mia mamma, mi liberai con uno strattone, e corsi via».
Da quel lunghissimo, interminabile pomeriggio, il piccolo Giuseppe non vide mai più né madre né nonna. Rammenta, alla fine della guerra, la confusione della gente che assaltava la stazione di Torino Porta Nuova per l’arrivo dei reduci. Anche lui, con il padre, faceva rotta a quel luogo dove l’attesa e la speranza si davano la mano, tra fotografie esibite, richieste di informazioni, urla, pianti, occhi che inseguivano volti in cui riconoscere la fisionomia di chi non era ancora tornato. Solo poco tempo fa, accompagnato dalla figlia e dalla nipote, Rav Laras si è recato nel lager di Ravensbrück, ottanta km a nord di Berlino, dove perirono le donne della sua famiglia. Scorrendo un vecchio registro, trovò anche la data di morte della madre: 29 dicembre 1944.
Desta meraviglia la precisione con la quale i nazisti annotavano i dati anagrafici dei prigionieri e fa orrore la scrupolosità con la quale era stata messa a punto quella macchina dello sterminio e della vergogna, come se fosse una prassi consolidata che alcune persone avessero il diritto di vivere, ed altre il dovere di morire. Ecco perché
«bisognerà continuare a parlare di quello che è successo, tuttavia – chiarisce il rabbino – l’obiettivo fondamentale non dovrà essere unicamente quello di consegnare ai posteri questa memoria, bensì di trasmettere un atteggiamento di netto rifiuto della violenza e dell’intolleranza talché esso possa diventare parte integrante del patrimonio etico-culturale delle donne e degli uomini di domani. Questo è l’obiettivo della conservazione della memoria, una memoria dinamica che costruisca e non si pianga addosso».
Rav Laras sembra svelare il comandamento della memoria attraverso una formula: «ricordare per ricostruire» perché non venga mai più messo in discussione il senso etico dell’esistenza. Di qui i doverosi interrogativi sulle acquiescenze, le intolleranze, le connivenze anche da parte del mondo cristiano e della cultura laica europea, che resero ancora più foschi quegli anni:
«amici e conoscenti non ebrei, il giorno dopo la promulgazione delle leggi razziali, facevano finta di non conoscermi».
Ma anche la condanna più ferma di una pseudo-storiografia di stampo negazionista.
Misurarsi con questa catastrofe significa guardare in faccia la sfinge. Mettere al centro il problema del male e della sofferenza, chiedendoci non tanto dove fosse Dio, mentre si stava consumando l’orrore, ma dove fosse l’uomo. La questione da teologica si fa antropologica:
«Il ricordo di Auschwitz – ammonisce lo studioso – deve diventare l’emblema di un’umanità nuova che risulti immune da ciò che ha reso possibile la Shoah, con il suo bagaglio di devastazione e di morte».
Ecco perché occorre insistere sull’impiego di una memoria dinamica.
Rav Laras richiama il Qohelet:
«C’è un tempo per tacere e un tempo per parlare».
Noi abitiamo ancora nel tempo della parola, che esige responsabilità, impegno, tenacia. Un tempo, tuttavia, in cui riconoscere Altri sembra ancora difficile, anche se questa resta l’unica via per incamminarsi verso un futuro migliore e per realizzare il fondamento stesso della nostra umanità: quello che Levinas, nei Carnets de captivité, chiama la felix culpa – teologumeno interpretato in chiave pre-cristiana – il «dovere felice» di amare l’altro, di lenire la sua sofferenza – foss’anche con il gesto messianico di una carezza, «significato corporale del tempo». Al punto da avvertire una perversa felicità nella stessa sofferenza:
«tutto il cristianesimo – rivela l’ebreo lituano – è già contenuto in questa scoperta che gli è ben anteriore».
Rav Laras si congeda con un triplice imperativo: ricordare, trasmettere, educare.
Sovviene una massima dei Pirqè Avot:
«Non spetta a te portare a termine il lavoro, ma non sei nemmeno libero di sottrartene».
F.N.